
L’antropologo Robin Dunbar stimò che 150 è il limite di persone con cui un essere umano può mantenere una relazione stabile. La capacità del cervello pone questo limite, e pare che le tribù umane siano solite rispettarla non crescendo oltre. Superata questa soglia la vita dovrebbe essere miserabile. È abbastanza evidente che non tutte le relazioni hanno lo stesso grado di complessità, e lo stesso Dunbar osserva – tra differenti specie – una curiosa correlazione che collega la misura del cervello con il comportamento sociale. Gli animali monogami, per esempio, tendono ad avere una maggiore attività cerebrale. Dunbar associa questa caratteristica al fatto di dover sondare a lungo il terreno prima di scegliere con chi – e come – vivere le diverse sfumature che sono proprie di una convivenza prolungata. Però, vedendo il tutto da un altro punto di vista, maggiori e brevi relazioni consumano meno neuroni rispetto alle relazioni più longeve.
Per alcuni anni si usava Facebook come prova del numero di Dunbar, perché sembrava rispettare il limite di 150 “amici”. In questi anni però è successo qualcosa che ha permesso a questo numero di diventare più del doppio, fino ad arrivare ad una media di 338. Infatti, il numero diminuisce con l’età, e le persone con meno di 24 anni tendono ad avere più di 600 “amici”. Potrebbe trattarsi di un cambiamento collettivo della nostra specie che incrementa la nostra capacità mentale. Però, visto lo stato dei fatti, sembra più proponibile pensare che si siano create forme di “amicizia” meno costose, e che a livello di attenzione neuronale siano meno “impegnative” se rapportate alle forme tradizionali.

Questo non significa che l’incremento eccessivo di amicizie sopra il numero di Dunbar non crei irritazione, e la parola «unfriend» (eliminare qualcuno dalla lista dei propri amici) si è aggiudicata il premio come parola dell’anno 2009. Addirittura, il 17 di novembre, si celebra la giornata mondiale dell’”eliminazione degli amici”. Quelli che agitano maggiormente le sinapsi per il loro eccesso di pubblicazioni dovrebbero essere i primi candidati. Non si sa se sia maggiore il piacere di eliminare qualcuno che si segue su internet, piuttosto che aggiungere per sempre qualcuno che già si conosce nella vita reale. Da un club di amici, Facebook sta incominciando a diventare un freezer ben ordinato che congela le relazioni che hanno quasi cessato di essere amicizie, assieme a tutte le altre che potrebbero iniziare ad esserlo. Una sorta di miscela tra tamagochi e rolodex.
Allo stesso tempo, le indagini indicano che nel mondo reale meno del 50% della gente è solita indicare più di tre amici come amici veri. Questo corrisponde di più alla definizione della RAE (Real Academia de la lengua Espanola), per la quale l’amicizia è «affetto personale, puro e disinteressato, che nasce e si rinvigorisce col tempo condividendolo con un’altra persona». Quello di «condividere con un’altra persona» sembrerebbe ridondante se non fosse per altri studi, i quali dimostrano che più della metà degli intervistati identificano come amici proprio quelle persone che non rispondono – allo stesso modo e in maniera reciproca – a tale affetto nei loro confronti. Tale evidenza salta subito all’occhio se la si confronta con la predisposizione dei cani, che solitamente ci lasciano una prova incondizionata in tema di affetto.
A questo punto si apre un interessante quesito: di quanti amici abbiamo bisogno? Lo scontroso Pío Baroja calcolava che «nella vita un amico è molto, due sono troppi, tre sono impossibili». Tuttavia, nel film Harvey, il socievole Elwood (interpretato da James Stewart) sosteneva che mai si può dire di una persona che possa avere troppi amici da non averne altri. Sfortunatamente, la preferenza di Elwood per un amico in particolare toglie autorità alla sua affermazione. Che quell’amico sia Harvey, un coniglio gigante e invisibile che sempre lo accompagna in giro per i bar, non fa che delegittimarla maggiormente.
Per rispondere quindi alla domanda di cui sopra, si dovrebbe prima rispondere alla domanda «che valore ha un amico». Da questo punto di vista, non tutti gli amici sono uguali. Per esempio, sono meno gli amici che inviteresti a un matrimonio rispetto a quelli individuati sulla rete dei social network; meno quelli con cui parteciperesti ad attività di buon cameratismo; ancor meno quelli a cui confideresti i tuoi sentimenti; e meno quelli che ti ospiterebbero in caso di sfratto.
Perché dobbiamo contare gli amici se non possiamo contare su di loro? La saggezza popolare compara gli amici ai taxi, proprio per la loro tendenza a non esserci nel momento del bisogno. L’investitore Warren Buffet diventò l’uomo più ricco del mondo. Però all’età di 82 anni, quando gli fu chiesto come misurava il successo nella vita, rispose – ispirato da un’amica sopravvissuta ad Auschwitz – che si basava sul numero di amici che si sarebbero nascosti se lui avesse avuto bisogno di loro.

Il testo del libro di Ecclesiaste, che è un testo saggio però abbastanza pessimista, si riserva qualche passo di conforto parlando degli amici nei momenti di difficoltà: «due sono migliori che uno; perché (…) se si cade, ci sarà uno a sollevare il suo compagno; però ahi! Per il solo! Perché quando cade, non ci sarà un secondo che lo potrà sollevare». Il messaggio strategico è chiaro: fatti degli amici prima di aver bisogno di loro, perché in seguito questo tentativo non funziona.
Inoltre, gli amici spariscono quando migliorano il proprio status sociale. Non dobbiamo dimenticare il ritornello che cantavano gli asturiani illegali: «Voglio diventare milionario, per dimenticarmi degli amici». A tal proposito, la storia della musica sembra comprovare che la formazione di un gruppo rock sia una forma abbastanza efficace per il dissolvimento delle amicizie.
A parte il contrattare un’ipotetica assicurazione nella disgrazia, gli amici prestano cose e servizi. Molte di queste funzioni (e in alcuni rapporti tutte) possono essere facilmente ottenute nel nostro sistema di mercato, che offre prodotti e servizi.
Il valore per ottenere un amico per un altro è complesso e consiste in un baratto. Sappiamo che questo non spaventa l’agenzia delle entrate, perciò nel resto dell’articolo mi riferirò a temi astratti.
Non vorrei iniziare a dare numeri o ad aiutare il signor ministro nel fiscalizzare gli amici, o ancora a calcolare un’ulteriore salita artificiale del PIL. Non voglio contribuire a che ci sia da pagare delle tasse per invitare a cena degli amici, né a che si aprano ulteriori filoni fiscali, come le economie di servizio intrafamiliari o di coppia.
Secondo internet, nel mercato vengono immessi degli steroidi, e le amicizie basate sulla reciprocità dei favori si vedono come minacciate. È una specie di corollario della teoria di Coase, che ottenne il Nobel per l’Economia rispondendo ad una domanda molto semplice: «Se i mercati sono così buoni, perché esistono le imprese?». La risposta ha a che fare con i costi di transazione, le insicurezze, le frizioni e le lentezze nel trovare fornitori o nel stipulare contratti. Allo stesso modo, quello che vediamo nell’industria discografica da Napster in poi, il finanziamento tramite il crowdfunding, il trasporto (Uber), l’alloggio (Airbnb) non sono altro che la nuova realtà di internet, che rimpiazza la tradizionale economia informale tra amici. Quelli amici che prima ti davano un passaggio in macchina, o ti offrivano alloggio per alcuni giorni, ora sono disponibili per il miglior offerente. Oggi è necessario rivedere la domanda di Coase, e chiedersi «se i mercati sono così buoni, perché dovrebbero esistere gli amici?»
Peggio ancora, nel mondo sviluppato, anche il cameratismo o la funzione sociale degli amici cominciano ad essere attaccati dai servizi commerciali sostitutivi. Nel mondo sviluppato, infatti, dove più di quattro ore al giorno vengono dedicate alla tv, le lunghe conversazioni tra amici sono già da tempo sporadiche, e quando accadono vengono spesso minacciate a causa della presenza degli smartphone sui tavoli. La tradizione che consisteva nel presentare il potenziale/futuro partner tra amici e conoscenti – e spesso l’insorgere stesso di nuove amicizie in queste occasioni – si sta perdendo a causa della presenza di numerosi portali specializzati adibiti a tale compito. Il “come stai” ora te lo dicono i wearables, e non più i tuoi amici quando t’incontrano per strada. Esistono anche servizi di “amici in affitto”, che, dal Giappone, si stanno pian piano sviluppando in tutto il mondo. E che qualcuno venga a piangere sulla tua tomba, beh, questo viene già commercializzato da secoli.
Così, da qui in poi, mi focalizzerò sull’intangibile, perché pare sia l’unico futuro dell’amicizia che ancora non sia stato professionalizzato o “piattaformizzato”. C’è da dire, fin da subito, che il titolo iniziale potrebbe avere due risposte: una persona ha bisogno di tanti “amici virtuali” per chiarire a se stesso la variabile tra il costo di gestirli tutti e l’ansietà per il raggiungimento del suo status (che da essi dipende). E che, inoltre, le tendenze attuali ci portano a credere che non abbiamo bisogno di nessuno amico reale, anche se – in termini di volontà personale – potremmo benissimo permettercelo.
Ma temo che questa riflessione stia prendendo una piega piuttosto scoraggiante. Si riducono le ragioni per coltivare le amicizie perché vengono offerti servizi già tagliati, impacchettati ed etichettati. Ha senso oggi quello che dice la RAE a proposito dell’«affetto personale, puro e disinteressato»? Alla fine il capitalismo annienterà le amicizie? Nota bene: non confondere tutto questo col concetto di «capitalismo degli amici» (clientelarismo, favoritismo, nepotismo, etc.), una pratica che, ultimamente, sta andando alla grande.
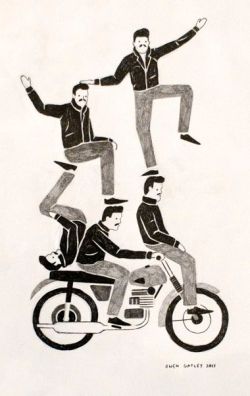
Mi è sembrato di identificare tre forme che potrebbero rendere sostenibile l’amicizia come fenomeno genuino.
La prima identifica gli amici nell’avventura. Nella nostra tradizione classica, il prototipo dell’amicizia è quello degli inseparabili Càstore e Pollùce. Amici che sono fratellastri, che vivono avventure insieme, e che si danno energia rischiando lealmente la vita l’uno per l’altro. È facile immaginarlo perché il cinema ci fornisce molti esempi di questo tipo nel genere “azione”. Per esempio, questa amicizia è alla portata di Lloyd e Harry nel film “Scemo più scemo”. Però accade anche in altre avventure scientifiche o intellettuali, come registrava il genere perduto della “corrispondenza epistolare”. O del genere della “buona politica”. Questo rapporto corrisponde al cercarsi per affrontare rischi e sfide assieme, con un proposito comune.
La seconda forma è l’amico che ti aiuta a migliorare. In India esiste il concetto di «kaliyana mitra», l’amico nobile che ti aiuta a superare i tuoi pregiudizi, confrontare la realtà e aiutarti così a crescere. I re e i principi hanno poche alternative per eludere i rischi di adulazione e superbia. Gracián raccontava che «ci sono uomini senza speranza per essere inaccessibili; si scagliano perché nessuno osa fermarli. Il più inflessibile deve avere una porta aperta all’amicizia che sarà anche quella del sollievo. Un amico deve avere sempre un posto di fiducia per poter comunicare e correggere nel momento dello sbaglio». Tutto questo non ha una funzione di monopolio nell’amicizia: meglio non parlare dei consigli di amministrazione, però il mercato fornisce mentori e coaches, fino a considerare addirittura i nemici che, beninteso, possono essere efficaci anche per questa funzione. Però è fin troppo ricorrente che le persone affermate sappiano identificare quelli che sono i loro grandi amici, talvolta sottolineandolo.
Una terza forma è quella dell’«amico dell’anima». C’è un comfort genuino nella vicinanza che ti danno gli amici, che non è né quella virtuale né quella per contratto. Platone raccontava che sin dall’inizio dei tempi ogni persona era due esseri in uno. Zeus ci castigò piegandoci per metà con il suo fulmine, e ora tutti cerchiamo, che lo vogliamo o no, quell’unica persona con cui condividiamo l’anima. Nella tradizione cinese, il termine «zhi yin» (conoscere il tono) rappresenta il fenomeno degli amici uniti per un filo più grande delle parole, per la leggenda in cui Ziqi capiva tutti i pensieri del suo amico Boya col solo ascoltare il suono della sua arpa. In forma simile, l’amicizia tra il mistico persiano Rumi e Shams Tabrizi ha ispirato migliaia di bellissimi versi.
Questo va ben al di là del fattore adolescenziale, che consiste nel “raccontarsi piccoli segreti”; però in qualche modo c’entra. Questi grandi amici sanno quello sono, e lo sono l’uno per l’altro, appoggiandosi nel dialogo. Come Thoureau, che aveva tre sedie nella suo rifugio nel bosco: una per la solitudine, l’altra per l’amicizia, e una terza per la società. Per Montaigne «l’amicizia che possiede e governa l’anima» non può accadere con tutti. Afflitto per la perdita del suo amico Étienne de la Boétie scrisse «l’amicizia comune può amare in un amico il talento, in un altro il carattere e in un altro ancora la generosità», però non in questa, che era «totale, e non esisteva in essa altro fattore o affare che l’amicizia stessa».
Penso che queste tre forme di amicizia esigano molto coraggio. Ognuna mette a rischio il comfort, il proprio modo di capire se stessi, o la protezione istintiva di fronte ad un’altra persona. Tutte si basano sul dialogo o, almeno, creano un filo proprio che può essere artistico o munito di un semplice sguardo. Tutte e tre fanno crescere, però hanno bisogno di tempo, e questo si scontra con l’impazienza dei nostri giorni. Tutte risultano sospettose della realtà esterna, forse perché l’intimità non è stata ancora compresa dal sistema. Competono con altre istituzioni e nel loro spazio sono libere, creative e radicali. Probabilmente, l’unica rivoluzione possibile incomincia proprio con l’amicizia.
Rafael Martínez Alonso
Traduzione di Edna Arauz e Francesco Paolo Cazzorla
Editing grafico a cura di Edna Arauz
Articolo originale: ¿Cuántos amigos necesita una persona?
Se hai trovato interessante questo articolo “Conformista” rimani aggiornato sulla nostra pagina Facebook, oppure iscriviti alla newsletter direttamente dal nostro blog.
AMICIZIA
di Fausto Corsetti
Quante volte iniziamo e terminiamo la giornata in solitudine, avendo come unico compagno di viaggio noi stessi e il nostro lavoro o studio? E quante volte anche un incontro veloce con un nostro amico o un sms che ci arriva mentre siamo di ritorno in auto, in treno, seduti soli o accanto ad un finestrino che l’ultima volta di mattina era illuminato dal sole e ora è buio…ci fa sobbalzare e sorridere?
Non si può vivere senza l’amico o l’amica; gli amici sono il tesoro più bello che esista. Non puoi stare senza averli sentiti per un giorno intero…
Nella vita sciatta di tutti i giorni noto spesso, però, con triste ripetizione lo sbandieramento quasi sfrontato – e a tratti cafone – di inutili trofei di relazioni, segno dei tempi; brutte copie di un sentimento che non s’incontra più: amicizia?
Più la gente disconosce principi e valori o, comunque, carica di valori inconsistenti la propria quotidianità, più la società diventa di massa, più l’amicizia diventa difficile e impraticabile. A meno di non intendere con questa parola amori che non si ha il coraggio di intraprendere, rapporti di coppia resi esangui dall’abitudine, conoscenze utili a scambi di favore, relazioni un po’ ipocrite e un po’ convenzionali nella speranza che un giorno possano tornare vantaggiose.
Ho l’impressione che oggi si sia quasi dominati da una sorta di grammatica delle relazioni basata esclusivamente sul “singolare” e il “plurale”.
Nel “singolare” incontriamo la solitudine del nostro intimo che vagheggia mondi e ideazioni che mai avremmo il coraggio di rivelare in pubblico, che si inabissa in dolori che la buona educazione ci induce a non manifestare, a tacere; che si esalta in entusiasmi che sfuggono a ogni misura e moderazione. Conosciamo quello che nel pubblico verrebbe additato come eccesso o follia. Anche se è proprio questa follia a darci vita, senso e coraggio.
Al “plurale” dobbiamo dar prova di sano realismo che ci chiede di stare ai fatti, di controllare le emozioni, di misurare le parole, di essere più una risposta agli altri che propriamente noi stessi. E tutto questo per essere accettati, riconosciuti, identificati, e nei casi estremi persino applauditi.
Ma l’amicizia non abita il “singolare” e il “plurale”, perché conosce unicamente il “duale”, categoria grammaticale con cui gli antichi Greci coniugavano le loro forme verbali quando il discorso era fra due, carico di quella valenza simbolica del linguaggio, che ben conoscono gli innamorati in quel breve periodo in cui non riescono a concepire se stessi senza l’altro.
Tra l’anonimato del pubblico e la solitudine del privato, l’amicizia, che abita il “duale”, consente di comprendere tutte quelle eccedenze di senso che nel segreto la nostra anima crea. Eccedenze che in pubblico potrebbero apparire come segni di follia, mentre nell’ascolto accogliente dell’amicizia possono dirsi e, invece di restare soffocate e inespresse, svelare la nostra intima verità. Per questo, penso, non si possono avere molti amici, ma soltanto quei pochissimi che corrispondono alle sfaccettature della nostra anima, a cui svelare il nostro segreto che l’altro segretamente custodisce.
Non solo per confidarci, cercare consenso o conforto, ma anche e soprattutto per vedere che cosa nella comunicazione duale il segreto ha da svelarci. Silenziosamente, a poco a poco, incontro dopo incontro. Perché così chiede il ritmo dell’anima, che vuole mostrarsi e insieme custodirsi, per non spegnere le sue creazioni e nello stesso tempo non disperderle nel rumore del mondo.
Se questa è l’amicizia, spesso la nostra cultura, così incline solo all’anonimato del pubblico e alla solitudine del privato, non è la più idonea a favorire quell’incontro a tu per tu con quello sconosciuto che ciascuno di noi è diventato a se stesso, e che lo sguardo accogliente dell’amico potrebbe iniziare a raccontare e a delineare nei contorni. Perché in fondo è proprio la scoperta di noi stessi che l’amicizia favorisce, propizia, accoglie.